| Aspettando Godot |
|
di Carmelo La Carrubba |
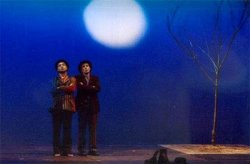 Fra
l’attesa e la speranza si sviluppa il capolavoro di Beckett
(1906-1989) “Aspettando Godot”
(1952) lo spettacolo andato in scena al Centro Zo alle ciminiere
con l’intrigante regia di Guglielmo Ferro che in questa
appropriata riduzione siciliana fa di tutto per avvicinarsi e capire e
far capire le intenzioni artistiche dell’irlandese che pur vagando –
apparentemente – nel vago aveva idee e convincimenti precisi sul modo di
fare spettacolo e sui contenuti metafisici da esprimere.
Fra
l’attesa e la speranza si sviluppa il capolavoro di Beckett
(1906-1989) “Aspettando Godot”
(1952) lo spettacolo andato in scena al Centro Zo alle ciminiere
con l’intrigante regia di Guglielmo Ferro che in questa
appropriata riduzione siciliana fa di tutto per avvicinarsi e capire e
far capire le intenzioni artistiche dell’irlandese che pur vagando –
apparentemente – nel vago aveva idee e convincimenti precisi sul modo di
fare spettacolo e sui contenuti metafisici da esprimere.
In questa commedia in cui non succede mai niente agiscono persone che
soffrono e sono felici e non hanno capito che stavano guardando la loro
vita, una metafora della vita qual è l’attesa del domani che sfocia nel
nulla e nell’attesa – in questa attesa – l’uomo svolge la propria vita:
tant’è, che è stato detto, che in questa “storia” che non ha un
inizio né una fine, ci ammalia perché è la nostra storia. Infine
quest’opera rivoluziona il dramma naturalistico trasformandolo in farsa
o – al limite – in una commedia “per passare due ore al buio senza
annoiarsi”.
Beckett vedeva il mondo come incomprensibile e l’uomo condannato a
compiere una serie di gesti privi di giustificazioni e di scopi. Una
visione del mondo che era stata già espressa da Sartre e Camus che però
nei loro testi teatrali avevano seguito dei procedimenti logici,
costruito intrecci attendibili e personaggi e idee riconoscibili (cioè
erano rimasti nei modelli del naturalismo) mentre in Beckett questo
cessa di esistere; cessava la favola, non c’erano personaggi né vicende
di cui seguire le peripezie, né una trama da seguire. Non c’era neppure
un messaggio esplicito. O non esplicito ma da ricercare: quello della
speranza che c’è nell’attesa che arrivi Godot. E la speranza – vi
chiederete – non è un segno carico di valori umani e metafisici?
Come Beckett aveva raggiunto questi risultati? Ma attraverso una visione
più che tragica grottesca della condizione umana. Inoltre alla
dissoluzione della trama si accompagnava quella del linguaggio, alle
tecniche tipiche del dramma si alternavano quelle del circo, del
varietà, del cabaret che derivavano dal surrealismo che dava libertà di
manifestazione a quello che l’individuo conservava dentro di sé, nel suo
mondo interiore.
In Godot una delle caratteristiche del testo è che nessun significato è
esplicito ma che ogni nome o situazione ne ricordano altre o sono la
metafora di una condizione o umana o spirituale senza dimenticare che
niente è dato per scontato: a chi chiedeva a Beckett chi fosse Godot
egli rispondeva che se lo avesse saputo lo avrebbe detto, in
un’altra che se lo avesse saputo non avrebbe scritto la commedia.
Il significato più ovvio deriva nel vedere in Godot il diminuitivo di
God (e questo comporta una lettura dell’opera come variazione sul tema
della morte di Dio); altra caratteristica come in Charlot di Vladimir ed
Estragon hanno la bombetta in testa, vestono abiti malridotti ma con
pretesa di eleganza com’è nel famoso vagabondo chapliniano, eroe
novecentesco. E infine a proposito di Godot, Beckett stesso una volta
ebbe a dire che il nome è sinonimo di “godasses” che è un sinonimo
popolaresco di scarpe (quelle scalcagnate: come quelle troppo strette di
Estragon o troppo larghe per i piedi di Vladimir). Infine Vladimir
significa etimologicamente “colui che porta pace, che stabilisce
l’ordine” mentre Estragon si rifà forse allo spagnolo “estrago” che vuol
dire “distruzione”. Forse Beckett non aveva in mente quanto detto ma è
certo che il contrasto fra i due personaggi è totale: Vladimir aspetta
Godot, Estragone, ammesso che aspetti qualcosa, attende solo la morte
che, a volte, progetta di affrettarla. Vladimir ricorda tutto. Estragone
dimentica ogni cosa. Vladimir solleva il problema dei due ladroni
crocifissi insieme a Cristo e definisce “una percentuale onesta” il
fatto che uno dei due si sia salvato. Sembrano i due vagabondi le facce
complementari della stessa stessa persona e infatti nonostante abbiano
opinioni diverse non riescono mai a dividersi. E poi c’è l’interrogativo
centrale su Godot dopo due appuntamenti in due sere consecutive debba
necessariamente non arrivare mai. Che alla fine è irrilevante perché
come abbiamo già detto il tema è l’attesa o meglio ciò che accade o che
può accadere mentre si aspetta: è anche un modo di fare trascorrere il
tempo che comunque passerebbe ugualmente nel tentativo di stabilire un
contatto di qualsiasi genere con un altro essere umano. Ed è impeccabile
la puntualità dei due nell’attendere Godot mentre dal loro
chiacchiericcio sembra affiorare un barlume di speranza. Il loro
linguaggio, le loro gag sono da circo, da varietà.
L’altra coppia è costituita da Pozzo e Luky: azzardiamo delle
interpretazioni: l’uno potrebbe essere il corpo l’altro la mente L’uno
il superego l’altro l’io; o si può fare una lettura sadomasochistica o
rappresentare una metafora sociale se non proprio della lotta di classe,
del rapporto fra padrone e schiavo in un sistema capitalistico in cui,
fra l’altro uno mangia pollo e gli altri solo le ossa. Eppure il povero
Luky sembra il più fortunato perché è senza speranza e non aspetta più
niente rispetto al suo padrone che appare tronfio e sicuro di sé nel
primo atto mentre è smarrito nel secondo perché è diventato cieco e
inciampa ad ogni ostacolo finendo goffamente per terra.
A questo punto ci chiediamo allora che cosa racconta “Aspettando
Godot”? Non c’è una risposta ma alcune possibili nessuna delle quali può
rendere conto di tutto. Semmai quello che resta è l’immagine di
questi personaggi ora patetici ora grotteschi riescono a lasciarci sulla
loro e la nostra condizione di uomini che cercano di trascorrere il
breve tempo concesso loro sulla terra accarezzando speranze che forse
non si realizzeranno mai, che sperano di trovare un senso alla loro
esistenza in ciò che fanno per restare in vita. I due atti finiscono
alla stessa maniera “Allora andiamo?” “Andiamo” si dicono scambiandosi
la battuta i due vagabondi ma “Non si muovono”.
La vivacità dell’opera sta ancora nella capacità che ha di far ridere
sulla miseria della nostra condizione.
Guglielmo Ferro ha dato consistenza
all’attesa e ha reso credibile l’assurdo di una situazione grottesca che
condiziona gli uomini con una regia intelligente che tiene conto
innanzitutto di ritmi scenici sostenuti che tengono desta l’attenzione
del pubblico e nello stesso tempo – ripeto – danno consistenza a quell’attesa
fatta di niente, danno possibilità all’attore di costruire – anche se in
maniera faticosa – il personaggio e di “raccontare” anche se in maniera
da circo, cabarettistica, metafisica una storia in cui i motivi comici
nel loro grottesco sono tristi e amari e il riso che scaturisce ritorna
in gola. Il merito oltre che della regia è degli attori bravi e
affiatati che hanno contribuito a creare questo straordinario gioco
scenico in cui sono presenti e ben rappresentati i motivi che abbiamo
sopra elencati trascinandoci – come pubblico – in questa avventura
artistica in cui abbiamo apprezzato bravura e maturità attorale nonché
l’ottima forma di Agostino Zumbo nel ruolo di Vladimir e del suo
contrario e alter ego Estragone di Rosario Minardi , inoltre il
personaggio di Pozzo delineato da Domenico Gennaro – il padrone –
che gioca col siciliano facendone risaltare musicalità e significati ben
coadiuvato da un ottimo Lino De Motta nel ruolo del servo. Infine
c’è Ivano Cerra il ragazzino che annuncia “il signor Godot,
arriverà sicuramente domani” al suo debutto: fresco spontaneo come la
speranza di cui è messaggero.
Una scena spoglia fatta di fogli di giornali ma carica di significati
col mitico albero al centro e una musica da varietà che apre e chiude lo
spettacolo che è stato ben apprezzato dal pubblico che l’ha a lungo
applaudito.
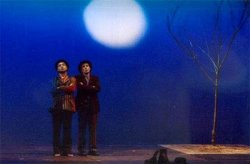 Fra
l’attesa e la speranza si sviluppa il capolavoro di Beckett
(1906-1989) “Aspettando Godot”
(1952) lo spettacolo andato in scena al Centro Zo alle ciminiere
con l’intrigante regia di Guglielmo Ferro che in questa
appropriata riduzione siciliana fa di tutto per avvicinarsi e capire e
far capire le intenzioni artistiche dell’irlandese che pur vagando –
apparentemente – nel vago aveva idee e convincimenti precisi sul modo di
fare spettacolo e sui contenuti metafisici da esprimere.
Fra
l’attesa e la speranza si sviluppa il capolavoro di Beckett
(1906-1989) “Aspettando Godot”
(1952) lo spettacolo andato in scena al Centro Zo alle ciminiere
con l’intrigante regia di Guglielmo Ferro che in questa
appropriata riduzione siciliana fa di tutto per avvicinarsi e capire e
far capire le intenzioni artistiche dell’irlandese che pur vagando –
apparentemente – nel vago aveva idee e convincimenti precisi sul modo di
fare spettacolo e sui contenuti metafisici da esprimere.