I
documenti paleografici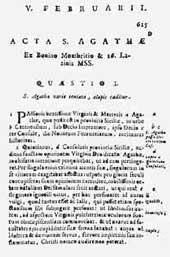
I documenti paleografici sono degli scritti antichi, redatti, prima che fosse inventata la stampa a macchina, su fogli o di papiro o di membrana ricavata dalla pelle di animali o, se si tratta di quelli più recenti, redatti anche su fogli di carta, attraverso i quali è pervenuto a noi il racconto del martirio di s. Agata.
1 - Il testo prototipo con cui fu redatto l'originario racconto del martirio di s. Agata
Tutti i documenti paleografici, che ci hanno trasmesso il racconto del martirio di s. Agata, originariamente dovettero far capo a un testo prototipo, da cui gli altri successivi testi necessariamente sono derivati.
2
- Le attestazioni sull'esistenza del testo prototipo
Tale testo prototipo, per riconoscimento del più noto critico storico delle gesta dei martiri cristiani, Albert Dufourcq, ed ovviamente anche di tanti altri, certamente esistette.
Esso venne compilato a conclusione della celebrazione del primo anniversario del martirio di s. Agata, in ossequio ad una prassi allora vigente ed attestata da s. Cipriano, vescovo di Cartagine, contemporaneo di s. Agata .
Tale prassi, per quanto riguarda il tempo precedente al martirio di s. Agata era stata attestata da due antichi documenti: uno della Chiesa di Smirne e l'altro della Chiesa di Lione. Il documento della Chiesa di Smirne è la relazione, che la comunità cristiana di Smirne nel 155 compose in merito al martirio di s. Policarpo e indirizzò a tutta la Chiesa di allora; nel testo di tale relazione i responsabili di quella Chiesa ribadivano l'impegno di convocarsi ogni anno presso la tomba del martire per celebrarne la vigilia prima che spuntasse l'alba; e tale impegno mantennero sempre, tant'è vero che il 12 marzo del 250, cioè meno di un anno prima del martirio di s. Agata, a Smirne fu arrestato il presbitero Pionio mentre celebrava la vigilia in onore di s. Policarpo .
Il documento della Chiesa di Lione è la relazione, che la comunità cristiana di Lione e di Vienne nel 177 composero in merito alla passione dei martiri di Lione e indirizzarono alle chiese della Gallia.
Per quanto riguarda il tempo successivo al martirio di s. Agata, quella prassi, nel 393, diventò norma, formalmente emanata e promulgata dal Concilio di Ippona, mentre vi era vescovo s. Agostino: con tale norma ai dirigenti delle chiese locali si ribadiva l'obbligo di celebrare l'anniversario
della morte di un martire, facendone leggere in chiesa la rispettiva passione. Successivamente il Papa Gelasio (a. 492-496) sottopose a previa censura tutte le "passiones" dei santi martiri, che andavano lette in chiesa .
3
- La dimostrazione dell'autenticità del testo prototipo, globalmente
considerato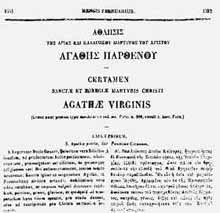
Si è certi che in tale epoca, la "passio" di s. Agata dovette ottenere il nulla-osta della censura romana: ciò si evince dal fatto che il testo della messa propria di s. Agata in quel tempo venne inserito tra le messe dei martiri riportate nel "Sacramentario Gelasiano", che è il primo testo liturgico delle messe della Chiesa Romana; e dal fatto che lo stesso Papa Gelasio dà notizia che al suo tempo c'era in Roma una basilica dedicata a s. Agata "in fundo caclamo": è questa la prima notizia dell'introduzione del culto di s. Agata a Roma. Dopo il Papa Gelasio (a. 492-496), il suo successore, Papa Simmaco, nell'anno 499 costruì e dedicò a s. Agata in Roma un'altra basilica "in fundum Lardarium" .
Intanto sin dall'anno 382, a testimonianza di s. Agostino , nella chiesa milanese e nelle altre chiese del mondo di allora, si era introdotta e già diffusa la rituale celebrazione della ufficiatura canonica, consistente nello svolgimento di particolari funzioni liturgiche, in cui si recitavano preghiere e salmi, intercalati con le lezioni agiografiche, tratte dai racconti delle passioni dei martiri. Tra tali lezioni agiografiche ci furono quelle tratte dalla redazione latina del martirio di s. Agata. Giovanni Bollando infatti attesta che la "passio" latina del martirio di s. Agata fu adottata come lezione agiografica da "epoca immemorabile", essendo stata accolta da tutte le Chiese latine ed inserita nelle loro ufficiature canoniche . A tale epoca risale la composizione dei più celebri inni latini indirizzati a s. Agata, il cui testo esplicitamente allude al fatto, che essi venivano cantati o recitati in occasione della ricorrenza del giorno anniversario del suo martirio: tale è l'inno che va attribuito a s. Damaso Papa (a. 366-384) e tale è l'inno a s. Agata riportato da s. Isidoro (a. 570-636), il quale peraltro rileva che esso era stato tratto da "vetustissimis scriptis" . Di tali inni ho già fatto l'esame critico-storico nel cap. II, lett. A, d) della citata mia opera.
4
- La dimostrazione dell'autenticità del testo prototipo nei suoi singoli
particolari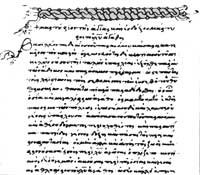
Quel testo prototipo del racconto del martirio di s. Agata, oltre ad essere suffragato da testimonianze ad esso estrinseche, che ne garantivano l'autenticità globale, conteneva tali elementi intrinseci, che ben evidenziavano l'autenticità dei singoli episodi, da esso riferiti.
Tali elementi intrinseci sono: il fatto che il redattore dichiara in prima persona ed assicura perentoriamente di aver visto e ravvisato un angelo in quel giovane, che depose la lapide di marmo, entro il sarcofago di s. Agata nel momento in cui il di lei corpo venne seppellito ; il fatto che il redattore, dopo aver riferito che appena morta s. Agata Quinziano fuggì ed annegò nel fiume Simeto, assicura categoricamente, che proprio fino al giorno in cui egli scriveva, ancora nei gorghi del fiume il cadavere di Quinziano non si era potuto trovare; ed infine il fatto che lo stesso redattore, avendo già rilevato che, morta s. Agata, Quinziano andò a ricercare i parenti della Santa per arrestarli, rileva altresì che, appena morto Quinziano, nessuno più infastidì i parenti di s. Agata, fino al giorno in cui egli redigeva il racconto del martirio di s. Agata stessa : se si pensa che, dopo appena 60 anni dalla morte di s. Agata, il cristianesimo, sotto l'imperatore Costantino, diventò la religione ufficiale dello Stato Romano, si capisce benissimo che quella redazione del martirio di s. Agata dovette aver luogo esattamente non oltre qualche anno dopo lo stesso martirio della Santa.
5 - La redazione dei testi derivati dall'originario testo prototipo del martirio di s. Agata
L'originale testo protoripo del martirio di s. Agata, inizialmente era stato redatto appositamente per restare in dotazione della edicola cimiteriale, in cui ogni anno si celebrava la vigilia della sua festa; e le prime copie, che di tale testo vennero fatte, dovettero servire per essere trasmesse alle Chiese vicinori, così come è riferito nel racconto del martirio di s. Policarpo . L'uso di tale originario testo prototipo e di tali prime copie andate diffuse, dopo tanti anni dovette rendere sgualciti quei testi, fino a quando poi essi divennero addirittura inservibili ed illegibili.
L'autorevole storico Albert Dufourcq ci informa che, nell'arco di tempo che va dal pontificato di Papa Simmaco (a. 498-514) al pontificato di Papa Ormisda (a. 514-523), il testo del racconto del martirio di s. Agata assieme ai testi delle gesta di altri martiri furono sottoposti ad accurato studio ed a diligente opera di revisione e di riedizione, grazie all'impegno di quei vescovi agostiniani, che, avendo le loro sedi nella fascia della zona settentrionale dell'Africa con epicentro a Cartagine, in seguito all'invasione vandalica, sferrata dall'allora re dei Vandali Trasamondo (a. 504-524), furono rimossi dalle suddette loro sedi ed esiliati in Sardegna .
Detti vescovi, durante gli anni del loro esilio e nel clima di quella nuova ventata di persecuzione, sotto la guida di s. Fulgenzio vescovo di Ruspe, erano riusciti a fondare un monastero nei pressi di Cagliari, formando uno di quei cenacoli di studio, che il Dufourcq ripetutamente segnala e qualifica come "circoli agostiniani". Presso tali circoli i suddetti vescovi si dedicarono a quel mirabile studio, che li impegnò a rieditare e a diffondere la narrazione delle gesta dei martiri.
Assieme a s. Fulgenzio vescovo di Ruspe, c'era anche suo nipote Fulgenzio Ferrando, celebre scrittore, teologo e canonista.
S. Fulgenzio morì nell'anno 534 e, subito, Ferrando ne scrisse la vita in lingua latina , perché i cristiani d'Africa parlavano in latino.
Il Dufourcq ha accertato che Ferrando stesso fu il rieditore del testo del martirio di s. Agata, per le evidenti affinità, che si riscontrano tra i suddetti due testi della vita di s. Fulgenzio vescovo di Ruspe e quello del martirio di s. Agata.
Tale riedizione del testo del martirio di s. Agata, curata da Fulgenzio Ferrando, rimpiazzò i vecchi e logori esemplari dell'originario testo prototipo del martirio di s. Agata: i manoscritti di tale riedizione furono subito diffusi e così si spiega come ora a noi siano pervenuti n. 140 manoscritti della redazione latina del martirio di s. Agata.
Il Dufourcq riferisce ancora che la Chiesa di Roma sostenne generosamente quei vescovi, servendosi all'uopo dei così detti monaci sciti, di lingua greca, i quali per ordine del sopra menzionato Papa Ormisda (a. 514-523) curarono l'assistenza economica degli stessi vescovi esuli . Dall'incontro fraterno tra i vescovi agostiniani d'Africa,
impegnati nella riedizione delle memorie delle gesta dei martiri ed i monaci sciti, assertori dell'ortodossia cristologica romana, espressa con la celebre formula "Gesù Cristo che vive e regna con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo", ne nacque una corrente di reciproca influenza: i rieditori di quelle agiografie, permeando i loro scritti della dottrina agostiniana sulla grazia, vi accentuavano i principi cristologici e trinitarii, di cui i monaci sciti si facevano banditori; i monaci sciti a loro volta si rendevano utili a quei rieditori in due modi e cioè anzitutto, in quanto greci, col tradurre in lingua greca quelle agiografie redatte in lingua latina e poi anche col farsi veicoli della diffusione di quelle memorie agiografiche, che facevano pervenire e recapitare presso i vari monasteri di allora .
A conferma di quanto sopra, il Dufourcq rileva che fu proprio in quel tempo e cioè sotto i Papi Simmaco (a. 498-514) e Ormisda (a. 514-523), allorché erano in auge i monaci sciti, che esplose e fiorì il culto di s. Agata a Roma, con l'erezione di due basiliche: una "in fundo caclano" e l'altra lungo la via Aurelia "in fundum Lardarium" .
Infine, il Dufourcq ci fornisce una preziosissima notizia, relativa agli anni di cui sopra. Egli rileva che in tale tempo la Chiesa Romana possedeva un cospicuo patrimonio terriero in Lucania ed in Sicilia: e, per amministrarlo, i Papi si servivano dei sopra detti monaci sciti, come ho detto di lingua greca. In Sicilia poi il suaccennato patrimonio era così vasto, da richiedere la presenza di due amministratori, residenti l'uno a Catania e l'altro a Palermo . Tale particolare fatto fornì l'occasione propizia, per cui, come ho già detto, il testo latino del martirio di s. Agata, assieme a quello di s. Lucia e ad altri, venne tradotto in greco, ma, nell'esser tradotto in greco, purtroppo il testo di s. Agata fu manomesso, in modo che, in tali traduzioni greche, si facesse distinzione tra il luogo di origine degli antenati di s. Agata, ed ovviamente anche di lei, ed il luogo di residenza della stessa s. Agata nel momento in cui essa fu arrestata .
Praticamente allora sarà accaduto quanto segue.
I monaci sciti a Cagliari, al tempo di Papa Ormisda (a. 514-523) quando ancora l'Italia non era "eparchia" dell'Impero Romano d'Oriente, tradussero la redazione latina del martirio di s. Agata in greco: questo testo greco pervenne a Palermo.
Nel 540 Belisario concluse l'occupazione della Sicilia e dell'Italia, sottomettendola come eparchia dell'Impero Bizantino e mettendo a Palermo un metropolita greco per reggere la Chiesa di Sicilia.
A Palermo, in tale epoca, i monaci sciti, amministratori del patrimonio terriero appartenente alla Chiesa Romana, ebbero in mano quella traduzione greca del martirio di s. Agata che era stata redatta a Cagliari; e si accinsero a trascriverla in manoscritti destinati ai vari monasteri greci, collegati col metropolita di Palermo.
Durante tali lavori di trascrizione effettuatisi a Palermo si dovette verificare un contrasto tra gli amanuensi. Si fu d'accordo nell'inserire la notizia secondo cui s. Agata sarebbe stata arrestata a Palermo, da dove poi sarebbe stata tradotta a Catania; e che, dopo l'arresto, i Palermitani avrebbero abbandonato s. Agata.
Uno degli amanuensi però, che chiamo A, inserì pure le notizie secondo cui: l'Italia in quel tempo era un'eparchia dell'Impero Bizantino; s. Agata sarebbe stata oriunda di Palermo; i suoi parenti sarebbero stati, non solo nobili, ma anche ricchi; e Quinziano, appena morta s. Agata, si sarebbe diretto a Palermo, per confiscare i beni di Agata e arrestare i suoi parenti.
Un altro amanuense invece, che chiamo B, non volle inserirvi né la notizia secondo cui 1' Italia era un'eparchia dell'Impero Bizantino né la notizia secondo cui s. Agata era oriunda di Palermo.
Il fatto poi che due manoscritti greci rimarcano che la Patria di s. Agata era Catania dimostra che il loro amanuense, che chiamo C, non proveniva da Palermo e che nel tempo precedeva tutti gli altri amanuensi, redattori dei manoscritti greci del martirio di s. Agata.
All'amanuense A fanno capo i 18 manoscritti greci, che contengono il testo del manoscritto parigino n. 999; all'amanuense B fa capo il testo dell'encomio di S. Metodio a s. Agata ; all'amanuense C fa capo il testo del manoscritto greco del Senato di Messina e quello della Biblioteca Regionale Centrale di Palermo collocato nel vol. 1, n. II, E, 8 .
Nell'anno 523 morì il Papa Ormisda. Subito dopo, nel 527, l'Imperatore Giustiniano da Costantinopoli mandò in Sicilia lo stratega Belisario, il quale sbarcando con una grande flotta a Catania liberò prima la Sicilia e poi l'intera Italia dall'invasione dei Goti, in modo che nel 540 annesse la nostra penisola all'Impero Romano d'Oriente, rendendo l'Italia una "eparchia" e cioè una provincia dell'Impero di Bisanzio; ciò è importante, perché così sappiamola data, dopo la quale poterono essere redatti i 18 manoscritti greci, ove è appunto detto che 1' Italia era una "eparchia" dell'Impero Bizantino e contestualmente è anche detto falsamente che s. Agata era oriunda di Palermo.