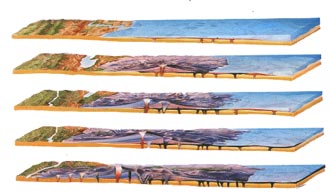| Vulcanologia |
|
| Il contesto geodinamico |
|
|
L’evoluzione
del contatto tra le placche litosferiche africana ed
euroasiatica, ha conosciuto diverse fasi di collisioni e
distensione che hanno portato alla frammentazione della struttura
litosferica originaria, creando un mosaico di microplacche
africane ed europee più o meno stabili. A partire dal Cenozoico
la tendenza geodinamica dominante è la convergenza dei margini
continentali.
L’area
etnea e l’arcipelago eoliano non sono gli unici centri vulcanici
siciliani.
Il Vulcanismo Mio-Pliocenico dell’altopiano Ibleo e del siracusano, l’isola Ferdinandea al largo di Sciacca (Luglio 1831),
le emissioni di vapori e le sorgenti termali di Pantelleria e di
Lipari, le fumarole sottomarine presso Salina e Panarea, le
"stufe" del monte S. Calogero presso Sciacca, le sorgenti
termali di Acireale, di Termini Imerese, di Castroreale
Bagni, di Alì, le "Salinelle" di Paternò e
Belpasso, le emissioni
del lago del Palici a Palagonia sono alcune delle manifestazioni
secondarie di un vulcanismo che ha profondamente "segnato"
la geomorfologia dell’isola.
|
|
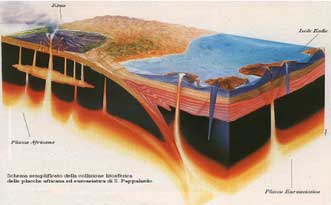
|
Verso
la fine dell'attività dei Centri eruttivi del Trifoglietto (Olocene),
si ebbe una significativa migrazione verso nord-ovest dell'asse eruttivo
principale di alimentazione magmatica. I prodotti emessi negli ultimi
27.000 anni, hanno determinato la formazione di un altro imponente
vulcano-strato, il Mongibello sensu strictu. Studi geofisici,
geologico-stratigrafici, geomorfologico-strutturali e
minero-petrografici, hanno permesso agli studiosi, di delineare due
differenti Unità: il Mongibello antico o Ellittico e il Mongibello
recente o attuale
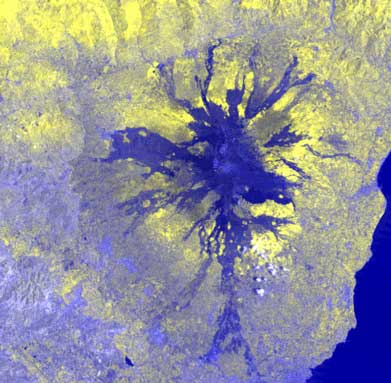
Con
un diametro basale pari a circa 40 Km, un'area pari a circa 1.265
Km2 ed un'altezza superiore ai 3.340 m s.l.m.
(basamento di spessore complessivo pari a circa 2.000 m). è uno dei
complessi vulcanici più grandi del mondo ed il maggiore in europa.
Gli
antichi conoscevano già la natura vulcanica di tale
"montagna".
Diodoro Siculo ci ricorda che, circa 3.000 anni fa, a causa di attività
violentemente esplosive (oggi conosciute come attività sub-pliniane e
caratterizzate dal deposito di estese coltri di materiali tufacei,
talora formati con meccanismi di "nube ardente" o di colate di
fango: "lahaar"), l’Etna costrinse i Sicani a ritirarsi
nelle parti occidentali dell’isola.
La
genesi dell’Etna si integra con l’evoluzione del bacino del
mediterraneo.
Il vulcanismo etneo è legato al fatto che l’area in questione è
molto prossima alla zona di collisione tra la placca euroasiatica
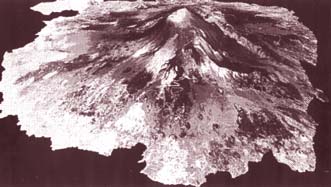 a
nord e quella africana a sud. Questa situazione geodinamica mentre da
luogo a nord al vulcanismo essenzialmente acido (riolitico-riodacitico-andesitico)
dell’arcipelago eoliano per la fusione parziale della crosta
continentale della placca africana che subduce sotto quella euroasiatica
favorisce a sud l’apertura di fessure distensive profonde nella crosta
che permettono la risalita dei magmi dal mantello superiore (astenosfera). a
nord e quella africana a sud. Questa situazione geodinamica mentre da
luogo a nord al vulcanismo essenzialmente acido (riolitico-riodacitico-andesitico)
dell’arcipelago eoliano per la fusione parziale della crosta
continentale della placca africana che subduce sotto quella euroasiatica
favorisce a sud l’apertura di fessure distensive profonde nella crosta
che permettono la risalita dei magmi dal mantello superiore (astenosfera).
Sin
dal XVIII secolo gli studiosi, Carlo Gemmellaro in testa, si resero conto
che non erano in presenza di un unico grande edificio vulcanico ma almeno
di due (il Trifoglietto e il Mongibello) che si erano succeduti e
sovrapposti nel tempo.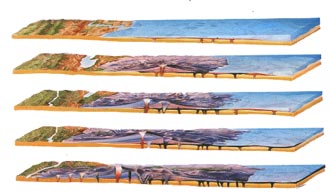
La successione dell’attività vulcanica riconosciuta finora nella
regione etnea risulta costituito da prodotti iniziali a chimismo
tendenzialmente tholeiitico passanti a termini di serie alcalina.
L'Etna, presenta una struttura complessa (vulcano multiplo) dovuto
alla sovrapposizione stratigrafico-strutturale di prodotti eruttivi emessi
in tempi differenti, attraverso diversi sistemi di risalita magmatica
(assi eruttivi), in corrispondenza dei quali si sono formati diversi
apparati (Centri) alcuni dei quali sono tuttora riconoscibili o
interpretabili in base ai caratteri petrografici dei materiali emessi o
per la morfologia delle pendici (Cristofolini R., 1993)
Nel
substrato sono riconoscibili tre principali elementi strutturali: l’Avampaese
ibleo costituito da una potente serie carbonatica estesa dal Triassico al
Quaternario e interessata da ripetute manifestazioni vulcaniche basiche; l’Avanfossa
Gela-Catania e la Catena settentrionale, che rappresenta la
connessione tra l'appennino e le catene montuose del nord Africa (Cataena
appeninico-maghrebide). Essa consiste in una serie di coltri di ricoprimento
costituite da unità stratigrafico-strutturali a loro volta riconducibili a
differenti aree paleogeografiche. Le varie unità sono oggi il risultato di
fasi di deformazione succedutesi dall’Eocene al Quaternario.
Disegni
di Santo Pappalardo
Elaborazione grafica Salvo Caffo e Salvo Spina
|


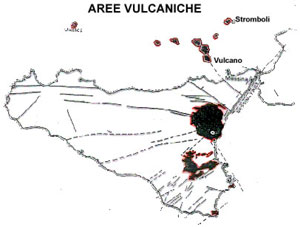
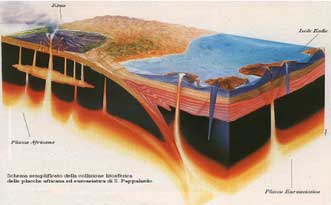
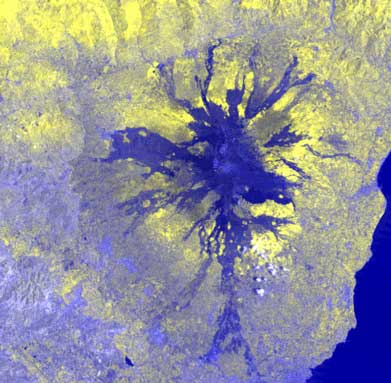

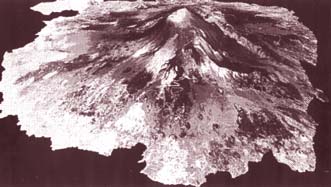 a
nord e quella africana a sud. Questa situazione geodinamica mentre da
luogo a nord al vulcanismo essenzialmente acido (riolitico-riodacitico-andesitico)
dell’arcipelago eoliano per la fusione parziale della crosta
continentale della placca africana che subduce sotto quella euroasiatica
favorisce a sud l’apertura di fessure distensive profonde nella crosta
che permettono la risalita dei magmi dal mantello superiore (astenosfera).
a
nord e quella africana a sud. Questa situazione geodinamica mentre da
luogo a nord al vulcanismo essenzialmente acido (riolitico-riodacitico-andesitico)
dell’arcipelago eoliano per la fusione parziale della crosta
continentale della placca africana che subduce sotto quella euroasiatica
favorisce a sud l’apertura di fessure distensive profonde nella crosta
che permettono la risalita dei magmi dal mantello superiore (astenosfera).